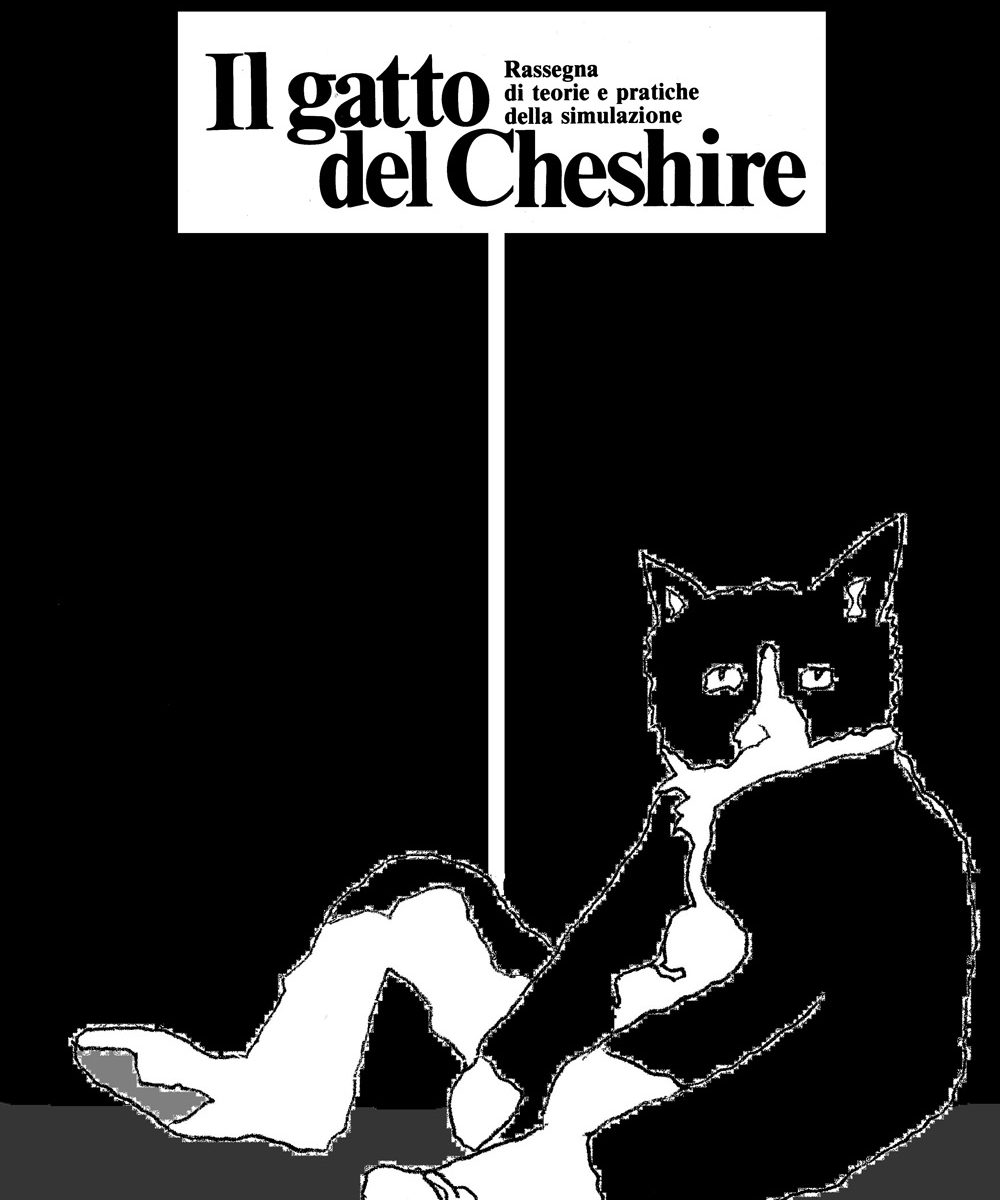Testo di Chiara Balsamo tratto da “Cinema indiretto”, tesi di diploma accademico di secondo livello del corso di Arti Visive e Studi Curatoriali
Naba (Mi), docente relatore Tiziana Villani, 2014
Il Gatto del Cheshire, Rassegna di teorie e pratiche della simulazione
Il 13 gennaio 1977 si inaugurò a Parigi il Centro Pompidu, Beaubourg. Il progetto originale venne concepito dall’allora presidente francese George Pompidu al fine di riportare Parigi allo status di capitale d’avanguardia e di indirizzare un pubblico sempre più ampio verso il mondo dell’arte contemporanea. L’apertura del museo scatenò violenti dibattiti soprattutto rispetto ai rapporti tra potere e luoghi della cultura.
Proprio negli anni Settanta, la critica museale si sviluppò con maggiore intensità e i presupposti di tale analisi vennero introdotti da Adorno, il quale definì l’istituzione museale come “sepolcro dell’opera d’arte” e metafora della produzione di beni di consumo della società borghese.
I problemi fondanti venivano identificati nel monopolio della fruizione dell’arte e nella decontestualizzazione delle opere. Si credeva che l’oggetto artistico privato del proprio contesto originale, tendesse a divenire un oggetto trascendente, e tale strategia veniva utilizzata dall’istituzione al fine di celarne i legami con la mercificazione e sottoponendo quindi l’opera ad un processo di feticizzazione. (1)
Alla luce di tali riflessioni, dalla fine degli anni Sessanta con il Concettuale, gli stessi artisti si opposero alla creazione di oggetti/merce attraverso la pratica di smaterializzazione dell’opera d’arte (2), inoltre nel decennio successivo con l’Institutional Critique si sperimentarono nuove strategie estetiche per mettere in luce il ruolo ideologico e politico giocato dalle istituzioni.
In tale contesto Baudrillard prese una posizione radicale inscrivendo il nascente centro Beaubourg nella categoria dei dispositivi de-realizzanti, descrivendolo come un modello di spazio per la socializzazione controllata e la simulazione operazionale della vita, la cui funzione era semplicemente quella di indurre una massa e di produrre un flusso umano e mentale omogeneo e disciplinato.
L’effetto Beaubourg, la macchina Beaubourg, la cosa Beaubourg – come darle un nome? Enigma di questa carcassa di flussi e di segni, di reti e di circuiti – ultima velleità di tradurre una struttura che non ha più nome, quella dei rapporti sociali ormai esposti alla ventilazione superficiale (animazione, autosuggestione, informazione, media) e ad un’implosione irreversibile in profondità. Monumento ai giochi di simulazione di massa, il Centro funziona come un inceneritore che assorbe e divora tutta l’energia culturale: un po’ come il monolite nero di 2001, convenzione insensata di tutti i contenuti, che qui si sono materializzati, assorbiti e annientati. (3)
Utilizzò il concetto di “effetto Beaubourg” inoltre per aprire una critica rivolta agli spazi sponsorizzati dal governo la cui sola aspirazione è di avvicinare le masse alla cultura al fine di neutralizzare e addomesticare il potere politico e creativo dell’arte. Così afferma nel testo L’effetto Beaubourg, implosione e dissuasione:
Una sperimentazione di tutti i differenti processi della rappresentazione: diffrazione, implosione, demoltiplicazione, aggregazione e disgregazione aleatorie – un po’ come l’Explorarium di San Francisco o nei romanzi di Philip Dick – in breve una cultura della simulazione e della fascinazione, e non sempre quella della produzione e del senso: ecco quel che potrebbe essere proposto senza cadere in una misera anticultura. E’ possibile? Non qui, evidentemente. Ma questa cultura si fa altrove, dovunque, in nessun luogo. (4)
Tale proposta provocatoriamente espressa da Baudrillard venne resa possibile con l’evento il Gatto del Cheshire, rassegna di teorie e pratiche della simulazione, organizzata dalla cooperativa Un’ambigua utopia con la collaborazione della rivista Alfabeta. Per quattro giorni, dal 20 al 23 maggio 1982, la sede della società Umanitaria di Milano ospitò una serie di eventi e dibattiti dedicati al tema della simulazione, articolata nelle sezioni di arti visive, musica, teatro, tecnologia, cinema, interventi. Come riportava il comunicato stampa:
Perché la simulazione? Dice lo Zingarelli: “Simulare – Fingere, far parere che ci sia qualcosa che n realtà non c’è – (tecn) Riprodurre qualcosa artificialmente in modo che sembri vero”. Ma oggi è proprio la produzione e riproduzione artificiale di oggetti, immagini, notizie, fatti che in qualche modo crea la realtà. Non “verità”, ma effetti di “verità”, mediati, fatti passare attraverso dispositivi e tecnologie il cui ritmo di crescita e di innovazione diventa arte integrante delle loro prestazioni, e perciò, potremmo dire, della loro “natura”. Questi quattro giorni di viaggio attraverso, appunto, le tecnologie, i giochi, il teatro, il cinema, la musica, le arti e la riflessione che tutto ciò ha suscitato, vogliono documentare la presenza della pratica e della e della teoria della simulazione nella nostra vita: per dare un contributo (questa è l’intenzione) alla comprensione del mondo in cui viviamo.
L’insegna di questo viaggio avrebbe potuto essere una delle mille figure della fantascienza, che ci è stata guida e spunto per tanta parte della preparazione di questa rassegna. Abbiamo preferito una figura altrettanto “contemporanea”, quella del gatto che appare e scompare nel Wonderland della Alice di Carroll: una allusione all’inafferrabilità del reale, alla dimensione del gioco, e insieme un omaggio a uno dei primi esploratori del territorio del non sense, al creatore di uno dei più densi e divertenti “spazi di simulazione” nei quali stiamo ormai imparando a vivere.
La rassegna si prefiggeva l’obiettivo di ricreare uno spazio di simulazione totale, in cui i visitatori potessero entrare in contatto con i più svariati processi di dissoluzione del reale. Il tentativo era quello di proporre una riflessione (a partire dalla dimensione esperienziale) sul mondo virtuale che stava prendendo sempre più piede nella società degli anni Ottanta.
(…) la crescente dimensione derealizzata, simulacrale, nella quale ci muovevamo, ci poneva già allora il problema di come rapportarci alle megastrutture dell’immaginario, di come continuare a praticare esperienze di opposizione e di alternativa quando le pratiche e gli strumenti tradizionali di lotta politica si rivelavano impotenti e inservibili. Era un tentativo di imparare ad abitare il mondo della virtualità: il termine non c’era ancora, il concetto e l’esigenza cominciavano già a chiarirsi. (5)
Nella sezione di Arti Visive, curata da Daniela Brambilla con la consulenza di Gillo Dorfles e Franco Origoni, vennero chiamati a partecipare ventinove artisti che gravitavano attorno al circuito milanese e che fossero in grado di cimentarsi con il tema dell’ambiguità della percezione e del simulacro. (6)
Il catalogo venne pubblicato come un numero speciale della rivista Un’ambigua utopia dedicato alla simulazione, all’interno di cui ognuno degli artisti partecipanti ha documentato un frammento del proprio lavoro o una breve articolazione testuale sui temi del Gatto del Cheshire.
Tra gli interventi più significativi che si potevano trovare in catalogo, Emilio Isgrò pubblicò Particolare (1974) un dettaglio di un ritratto fotografico di Nicola Cattedra ingrandito 427 volte, accompagnato da un breve enunciato: “L’arte è rappresentazione, diceva il vecchio Aristotele. Io non rappresento la realtà ma la distanza che mi divide da essa.”. Ugo La Pietra con un testo dettagliato, propose una riflessione su ciò che lui definiva “ferialità televisiva”, ovvero la perdita di alcune abitudini e ritualità festive in cambio di un utilizzo continuo dello strumento televisivo. La Pietra tracciava quindi i cambiamenti delle relazioni e della ritualità dello “stare insieme” attraverso l’osservazione dell’ambiente domestico e di come stesse cambiato in seguito all’introduzione della televisione. Il soggiorno – salotto veniva identificato come un luogo del non vissuto, immagine presente di una ritualità di cui era scomparso ormai l’uso.
Giulio Paolini presentò il celebre Giovane che guarda Lorenzo Lotto del 1967 che riproduceva nelle dimensioni originali il Ritratto di giovane di Lorenzo Lotto, rappresentando uno degli esempi più canonici della strategia di riappropriazione tanto sperimentata negli anni Sessanta. Paolini approfondì ulteriormente la riflessione sulla figura e sul ruolo dell’autore focalizzandosi soprattutto sull’idea di sparizione. Inoltre come affermava lo stesso Paolini è la “ricostruzione nello spazio e nel tempo del punto occupato dall’autore (1505) e (ora) dall’osservatore di questo quadro”. (7) “Il quadro si fa specchio mentale di una situazione, perché dà allo spettatore in quel momento l’illusione di trovarsi nella posizione, e quindi nella persona, di Lorenzo Lotto. Non vive quindi come quadro, ma come dichiarazione astratta”. (8)
La fotografia era qui utilizzata come strumento linguistico per “appropriarsi, attraverso il tempo, di una situazione che non si è vissuta nel reale, ma che si recupera attraverso il linguaggio”. (9)
Michelangelo Pistoletto presentò la documentazione fotografica dell’opera La porta obliqua e Il tempo a dondolo, accompagnando l’immagine con un testo:
Lo specchio ha la forma del metaglio e
piega obliqua la deriva.
Roma.
Un pendulo come scalpello
oscillando scava sotto la rocca,
rotondo, un obelisco che posa
all’altra parte del mondo.
Rosso punto cardinale del tempio che passa
alle sculture videnti dell’anno uno,
di gente parlanti portando sul capo
il teatro di colonne abbattute sul centro
di gravità.
Uno degli eventi più singolari della rassegna fu inoltre la mostra Laserart a cura della cooperativa Magic Bus di Bologna (cooperativa di produzione e diffusione di musica e arti visive). L’esposizione presentava una selezione di fotografie tridimensionali realizzate con la tecnica dell’olografia. Per gli anni Ottanta l’olografia rappresentava il più rivoluzionario dei mezzi di rappresentazione: varcava il limite della rappresentazione bidimensionale e sviluppava l’arte attraverso un medium con le medesime proprietà dimensionali dello spazio “reale”. La mostra comprendeva una trentina di opere esposte e per la prima volta in Italia venivano presentati degli ologrammi cosiddetti “integrali”, che grazie ad una tecnica mista oleografica e cinematografica permettevano la visione di una scena in movimento di una ventina di secondi. La maggior fascinazione consisteva nel fatto che l’immagine virtuale prodotta dell’ologramma non era semplicemente un’illusione ottica, ma si trattava bensì di un fenomeno fisico scientificamente registrabile e dimostrabile.
Per quanto riguarda il teatro, l’esperimento più interessante venne messo in scena da Il Marchingegno (l’attuale compagnia Krypton), un’esperienza che poteva essere definita come “teatro architettura” o “teatro ambientale”, ovvero una serie di interventi sullo spazio il cui obbiettivo era quello di ricreare viaggi immaginari all’interno dei luoghi del quotidiano attraverso la luce, la musica e le nuove tecnologie, capaci di trasfigurare e rompere la banalità degli ambienti.
Il Gatto del Cheshire rappresentò l’iniziativa più ambiziosa organizzata da Un’ambigua utopia e probabilmente fu anche quella che ne determinò la fine. (10)
Il collettivo, grazie anche alla pubblicazione dell’omonima rivista, rappresentò una delle più singolari esperienze culturali e politiche nate sulla scia del cosiddetto movimento del ‘77. I presupposti di questa breve storia sono da ricercare in ambito letterario, soprattutto in riferimento allo sviluppo di un nuovo modo di intendere la fantascienza che si sviluppò a partire dagli anni Sessanta, simultaneamente alla trasformazione dell’economia e della società in senso postfordista. Autori come James Ballard, Philip K. Dick, ma anche il più visionario William Burroughs seppero più di chiunque altro analizzare in maniera critica i nuovi scenari che il modello capitalista stava imponendo. Come scrive Antonio Caronia:
Era un lavoro sull’immaginario sociale, che, in sintonia con le tendenze emerse in Italia nel movimento del 77, utilizzava la FS non solo per le sue qualità letterarie, ma al contrario per la capacità che essa aveva di esprimere (con la necessaria ambivalenza) un modello sociale in ascesa e, all’interno di esso, le faglie e i punti di crisi che andavano preparando. (11)
La fantascienza venne scelta quindi dal collettivo come pretesto per sperimentare nuove pratiche di resistenza ad un modello politico dominante e sempre più pervasivo. Prendendo le distanze dagli appassionati del genere e dal mondo del fandom, Un’ambigua utopia definì come campo d’azione la politica e la cultura in generale; l’intenzione di elaborare un discorso che prendesse le distanze dalla concezione classica di fantascienza venne palesato nell’editoriale del primo numero pubblicato nel dicembre 1977:
Il capitale deve, per sopravvivere e svilupparsi reprimere i veri bisogni dell’uomo, per sostituirli con i suoi bisogni (creare nuovi prodotti e creare l’esigenza di consumarli), con un modello di vita e di società a lui congeniale (la famiglia, la scuola, la caserma, il lavoro salariato ecc.
La fantascienza è un segno di rivolta a tutto questo, è la riscossa del principio del “piacere” sul principio di “realtà”.
Avremo tempo di entrare nello specifico di questi concetti in articoli successivi; cerchiamo di porci ora il perché di questa rivista e soprattutto, chiarito che la matrice della SF è una rivolta della civiltà occidentale, distinguere la parte progressista (proiettata in avanti) da quella reazionaria (volta all’indietro, fuga, evasione, recupero di valori precapitalistici).
Chiariamo innanzitutto che la nostra iniziativa non si diversifica dalle altre, nel fatto che noi siamo dei “fans” compagni e per cui sosteniamo la SF di sinistra o progressista contro quella reazionaria.
Noi non siamo dei sostenitori della SF, non siamo dei fans.
Non vogliamo allargare, far crescere, propagandare la fantascienza.
VOGLIAMO DISTRUGGERLA.
Nel senso che vogliamo rompere questo involucro, questo contenitore che si chiama fantascienza, e dimostrare che ciò che contiene, ciò che c’è dentro, non è altro che quello che si trova fuori.
L’obbiettivo era quindi di aggirare l’idea comune di fantascienza, intesa come schermo del presente o come luogo di consolazione in cui prefigurare universi futuri più rassicuranti.
Nell’universo iperreale la distanza fra immaginario e reale è abolita, e il principio di simulazione si estende ad ogni campo dell’esistente sostituendosi alla realtà stessa. Il processo critico di metaforizzazione del presente viene quindi messo in discussione in favore di una pratica dell’utopia nel “reale”.
La trasfigurazione verso un immaginario fantastico diviene a tutti gli effetti base ontologica dello strumento letterario che come elemento attivo, smaschera il simulacro della rappresentazione, sovvertendolo e mettendo in luce la dimensione fantasmatica e allegorica dell’esistente.
- Shermann D. J., Quatremere/Benjamin/Marx: Art Museum, Aura, and Commodity Fetishism, testo tratto dal libro Museum Culture, Daniel J Sherman and Irit Rogoff , Routledge, Londra, 1994.
- Il concetto di smaterializzazione dell’opera d’arte venne introdotto Jhon Chandler e Lucy Lippard con l’articolo The Dematerialization of Art, pubblicato su Art International nel febbraio 1968. Nell’articolo decretavano la nascita dell’arte “ultraconcettuale” definendo una nuova forma d’arte che stava emergendo da due direzioni: arte come idea e arte come azione, e che prendesse le distanze dalla creazione di opere-oggetti.
- Baudrillard J., Simulacri e Impostura, Bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti, Milano, PGreco Edizioni, 1980.
- Ibidem.
- Antonio Caronia, Un’ambigua utopia, pubblicato sul n. 2, 1999, di MIR.
- Gli artisti partecipanti erano: Adriano Altamira, Valentina Berardinoni, Irma Blank, Gilberto Bonalumi, Alessandro Bonelli, Gaetano Cantone, Alik Cavaliere e Vincenzo Ferrari, Eugenio Carmi, Pietro Coletta, Di Bello, Paolo Gallerani, Emilio Isgrò, Ugo La Pietra, Giambattista Luraschi, Clara Mantiea, Fabrizio Merisi, Antonio Massari Mario NIgro, Gianfranco Pardi, Tullio Pericoli, Lucia Pescador, Michelangelo Pistoletto, Elisabeth Scherffig, Lucia Sterlocchi, Emilio Tadini, Giovanni Valentini, Grazia Varisco, Gianni Emilio Simonatti.
- Giulio Paolini in Giulio Paolini. 2121969, catalogo della mostra, Galleria De Nieubourg, Milano 1969.
8.Giulio Paolini nell’intervista di A. Bonito Oliva, in Paolini: opere 1961/73, catalogo della mostra, Studio Marconi, Milano 1973.
- Giulio Paolini in G. Celant, Giulio Paolini, Sonnabend Press, New York 1972.
- In 4 giorni densi e per noi indimenticabili passarono dai chiostri dell’Umanitaria Umberto Eco, Alberto Abruzzese, Omar Calabrese, Franco Bolelli, Maurizio Ferraris, Gilles Lipovetsky, Paolo Fabbri, Giuseppe Bartolucci, Daniele Brolli, Santagata e Morganti, Tommaso Kemeny, Carlo Formenti, Antonio Attisani, Il marchingegno (che poi sarebbe diventato Krypton), Alik Cavaliere, Emilio Tadini, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini e tanti altri, in un susseguirsi di interventi, installazioni, videotape, poesie, spettacoli teatrali, ologrammi, giochi di ruolo, videogame, musica. Il migliaio di persone che partecipò, come sempre in questi casi, non ebbe la percezione che gli incassi coprivano meno del 15% dei sessanta milioni che era costata l’operazione. Il contributo del Comune, che copriva circa metà del bilancio, arrivò dopo un anno. Il passivo, aggravato dai costi della libreria che dopo meno di due anni non era ancora pienamente avviata, ci affossò. Forse avevamo fatto il passo più lungo della gamba. L’ultimo numero della rivista (il nono della serie), che costituiva il catalogo della manifestazione, non venne neppure distribuito nelle librerie. (Antonio Caronia, Un’ambigua utopia, pubblicato sul n. 2, 1999, di MIR – Men in Red).
- Caronia A., Universi Quasi Paralleli. Dalla fantascienza alla guerriglia mediatica, Roma, Cut up edizioni, collana Strade perdute, 2009.